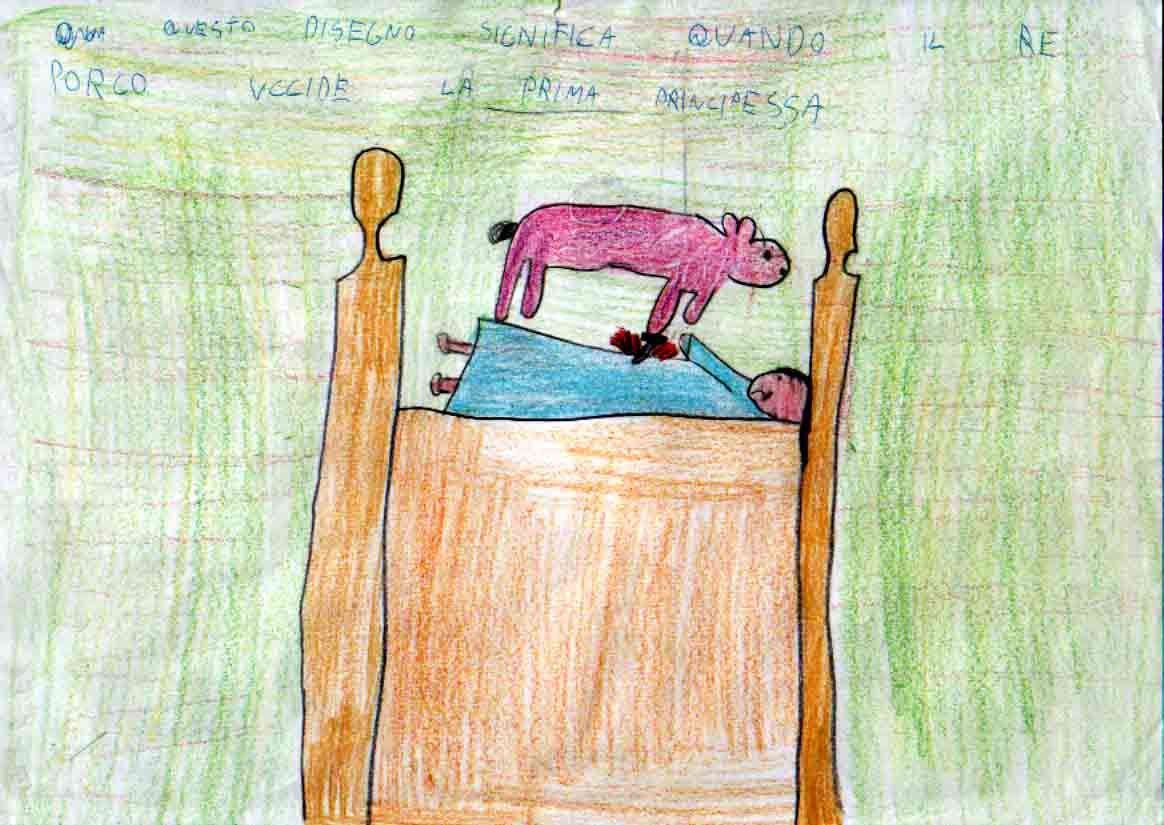|
|
| 1.
Quale fiaba. Si scelga una fiaba con le caratteristiche di ricchezza narrativa e di densità simbolica che caratterizzano sia molte fiabe antiche, sia molte fiabe raccolte alla fine del XIX secolo dai demologi in Italia come in tutta Europa: chi non intende condurre una ricerca personale può scegliere in questo sito fra le fiabe che ho reso in italiano per Giunti (Collana Gemini, Basile-Straparola, Le prime fiabe del mondo, Firenze 1996), o fra altre fiabe italiane, antiche, dialettali e alloglotte. |
| 2. Fra queste fiabe l’insegnante sceglierà quella che avverte come più bella e significativa, anche se non sa il perché e non ne conosce l’interpretazione. Nulla che non sia bello e sensato per l’insegnante potrà apparire tale ai suoi bambini. |
| 3. Per prepararsi,
l’insegnante che non abbia già fiducia in sé come
lettore narratore, legga ad alta voce la fiaba più
volte, ricorrendo al registratore per
riascoltarsi, o chiedendo di ascoltarlo ad altri.
Quando sentirà la propria recitazione come
efficace potrà leggere la fiaba alla classe. |
| 4. Ai bambini, prima
della lettura Agli alunni va detto che
la lettura della fiaba è un lavoro diverso dal
solito, precisando, in particolare, che non darà
luogo a nessun tipo di correzione o valutazione.
Si precisi che la fiaba che ascolteranno
antica, e che è considerata un pagina raffinata di
letteratura, di solito riservata a un ristretto
numero di studiosi. Si anticipi che non si darà
nessuna spiegazione sul significato di termini
difficili o strani, che fanno parte
dell’esperienza, o del gioco: i bambini non devono
preoccuparsi di quanto non capiscono, e sono
autorizzati a interpretarlo come meglio credono. |
| 5. Durante Nella mia esperienza,
dalla scuola materna alla media inferiore, e nei
gruppi di adulti, il silenzio del gruppo in
ascolto è intenso, di una qualità rara. Direi che
se non si realizza questo silenzio si può
considerare fallita l’esperienza: quale dei punti
precedenti non è stato rispettato o compreso? |
| 6.
Dopo Si lasci qualche momento
di silenzio, come dopo la proiezione di un film, e
poi si dica ai bambini che ora possono scrivere o
disegnare la storia, tutta, come un riassunto,
alcune parti, o anche una parte sola. Sono da
evitare frasi trite come ‘scrivi o disegna quello
che ti ha colpito di più’ o ‘che più ti ha
interessato’. Si dica che chi non vuole
partecipare potrà restare in silenzio, lasciando
lavorare gli altri. Si dia un tempo definito, in
base alle proprie esigenze - nella mia esperienza
va bene sia un quarto d’ora sia un’ora - e si precisi che chi non
disegna né scrive non darà il suo contributo per
il nuovo racconto della fiaba. A questo proposito
non si diano spiegazioni, neanche se richieste: si
mantenga il mistero, come per una sorpresa che si
sta preparando. In questa fase è indispensabile
che il narratore non intervenga in alcun modo se
non ribadendo quanto ha già precisato, né
correggendo nessun elaborato, né charendo nessun
fraintendimento, né dando la minima indicazione su
come procedere nel lavoro. Si può ribadire che non
possono esistere errori e che non ci saranno né
correzioni né voti per nessuno. Seguire questa
regola è indispensabile per creare uno spazio
diverso da quello usuale. |
| 7. Raccolta Si raccolgano e si mettano da parte con cura gli elaborati. Il narratore da solo, più tardi, li guardi senza fretta, senza preoccuparsi in un primo momento di come potrà usarli per la versione collettiva. Di solito la prima impressione è che i lavori siano poco significativi, ma continuando a osservare e a riflettere, possibilmente con qualche intervallo di tempo, a un certo punto cominciano a mostrare la loro ricchezza. |
|
8.
Organizzazione del materiale per |
|
8a.
ogni alunno deve essere rappresentato almeno con un disegno o con un brano, anche una sola frase, nella versione collettiva, perché ogni alunno senta che la sua voce, la sua parola, è parte integrante della versione collettiva; |
|
8b.
per ottenere un racconto che tenga, e che perda il meno possibile della ricchezza della fiaba letta, l’insegnante selezionerà prima di tutto i singoli passaggi riespressi dalla classe, anche se da un solo disegno o da una sola frase, in modo da inserirli nella versione collettiva; |
|
8c. se un alunno che mostra abitualmente poco
interesse alle attività didattiche ha lavorato con
particolare passione, il suo frammento di racconto
dovrebbe trovare una collocazione che valorizzi
questa partecipazione, ma senza enfasi, perché
resti in equilibrio con tutti gli altri;
|
|
8d.
dopo aver dato spazio a tutti i bambini, alcuni
dei quali possono aver scritto disegnato solo un
particolare, l'insegnante userà i riassunti che
aveva messo da parte, di solito scritti dagli
alunni di solito più attenti e produttivi; grazie
ai loro testi potrà dare la forma migliore e più
completa al tessuto della narrazione, colmando le
lacune dovute al fatto che la maggioranza degli
alunni di solito rappresenta soltanto due o tre
passaggi della fiaba;
|
|
8e.
quando l’insegnante sentirà di disporre di una
nuova versione della fiaba, interamente formata
dai frammenti narrativi tratti dai bambini, ricca
e significativa quanto quella originaria, anche se
piuttosto diversa, potrà passare alla fase
successiva.
L’insegnante esperto di fiabe e miti sarà sostenuto in questo lavoro dalla consapevolezza che le storie collettive sono frutto di continue trasformazioni, e che ogni narratore, colto o analfabeta, modifica la storia che ha sentito ogni volta che la rinarra. Se poi ha un'esperienza psicoanalitica, o se conosce almeno qualche studio sulla fiaba, come il lavoro dello psicoanalista freudiano B. Bettelheim o della junghiana M. L. von Franz (vedi Bibliografia) sarà consapevole dell'importanza della fantasmatica inconscia nella vita affettiva del bambino: partecipando sia di questa sia della fantasia cosciente, le fiabe sono esche di menzogna per verità segrete, difficili da condividere. La loro potenza risiede in questo, che è il motore della versione collettiva: per sperimentarla sono necessarie doti di pazienza, sensibilità, apertura, intelligenza, passione e una capacità lavorativa non comune, mentre la competenza psicoanalitica è preziosa ma non indispensabile. |
| 9. Presentazione
della versione collettiva In questo sito si posso osservare vari esempi di versioni collettive, relativi a esperienze nella scuola dell’obbligo. Fra i testi su questo tema accessibili online, fra le pubblicazioni di Adalinda Gasparini, vedi in particolare, per questa sperimentazione, Re porco e i bambini narratori, e L'orologio e la gemma. L’insegnante in questa fase dovrà dar fondo alle sue abilità di sceneggiatore e regista. Nelle mie prime esperienze, quando nessuna scuola aveva i mezzi tecnici ora presenti, la versione collettiva poteva essere solo scritta - possibilità poco praticabile prima della quinta elementare - e quindi recitata, oppure si potevano appendere con un certo gusto i disegni e i testi dei bambini, per poi vederli come una mostra d'arte, ripercorrendo con la regia dell’insegnante o del formatore la storia rinarrata. Il risultato è ottimo, e corrisponde al gusto dei bambini, utilizzando un computer e un videoproiettore: si costruisce un powerpoint con i disegni passati allo scanner e le trascrizioni - fedeli anche negli errori vistosi - degli scritti dei bambini che si sono scelti. Oppure si possono proiettare i disegni e leggere i testi, o anche proiettare solo i disegni: questo può essere necessario alla scuola materna e nei primi anni delle elementari, quando i bambini non sanno o non desiderano scrivere. Questa fase finale, la cui riuscita dipende dalla laboriosa fase descritta al punto 9, richiede un entusiasmo e una sensibilità, possibili come frutti di tutto il lavoro precedente. L’insegnante che proporrà ai bambini la versione collettiva di cui è regista, non sarà presente come personaggio, perché il suo lavoro servirà a fare il miglior film con gli attori e le risorse che ha a disposizione: se ci riesce è un buon regista. Se l’insegnante ha difficoltà tecniche, sarà utile che possa contare sull'aiuto di un altro adulto che lo supporti come tencnico durante la preparazione e la presentazione della versione collettiva. Sarà così più libero di orchestrare la regia. Nelle classi di scuola elementare, in cui parti essenziali della fiaba non erano state rappresentate, le ho fatte raccontare lì per lì dai bambini tra un disegno e l’altro: è però sicuramente meglio che gli alunni in questa fase siano solo fruitori. Il loro piacere è scoprire che come insieme, quasi un coro, hanno saputo raccontare la fiaba: che diventa a questo punto la loro fiaba, di ciascuno individualmente, e del loro gruppo come insieme. |
|
10. Conclusione Se ciò che
l’insegnante ha potuto osservare, nelle
proprie reazioni e nelle risposte del gruppo
classe e dei singoli alunni, non è ampio e
profondo, se per l’insegnante questa
esperienza non è particolarmente
significativa, si può dire che il lavoro della
versione collettiva non è riuscito. I motivi
possono essere molti, e andrebbero analizzati
volta per volta in un lavoro di supervisione:
se questa possibilità manca, è meglio che
l’insegnante cerchi altri metodi di lavoro. L’esperienza
personale di cui si parla in maniera sintetica
in questo decalogo, scritto
nel 2001 su richiesta di un gruppo di
insegnanti della scuola elementare di Castel
Mella (BS), che avevano partecipato
all’esperienza della versione
collettiva, sarà la condizione migliore
per comprendere e utilizzare i lavori che ho
scritto su questo tema. Vedi, in questo sito,
alcuni esempi
di versione collettiva) Per ulteriori
approfondimenti su educazione e psicoanalisi,
chi lo desideri potrà contattare direttamente
chi scrive tramite e-mail.
|
|
Questo
disegno significa quando il Re Porco uccide la
prima Principessa
Disegno e didascalia di un alunno di classe IV elementare dopo la lettura del Re Porco (A.S. 2001-2002) |
| PER CONTINUARE A LEGGERE E STUDIARE
LE VERSIONI COLLETTIVE |
|||
| VERSIONI ONLINE 1995-2012 |
VERSIONI IN DAD 2020-2021 | PSICOLOGY NEWS 26 APRILE 2021 | TESI DI LAUREA IN
PSICOLOGIA |
Online da 2 gennaio 2000
Ultima revisione: 26 aprile 2023