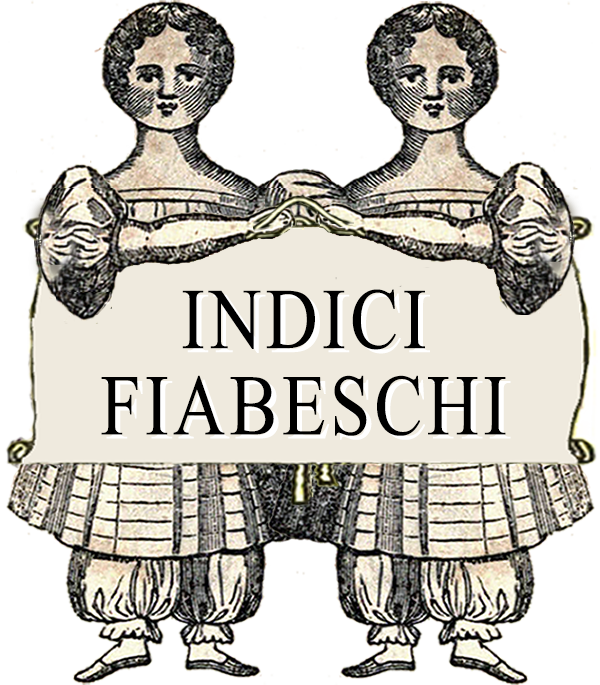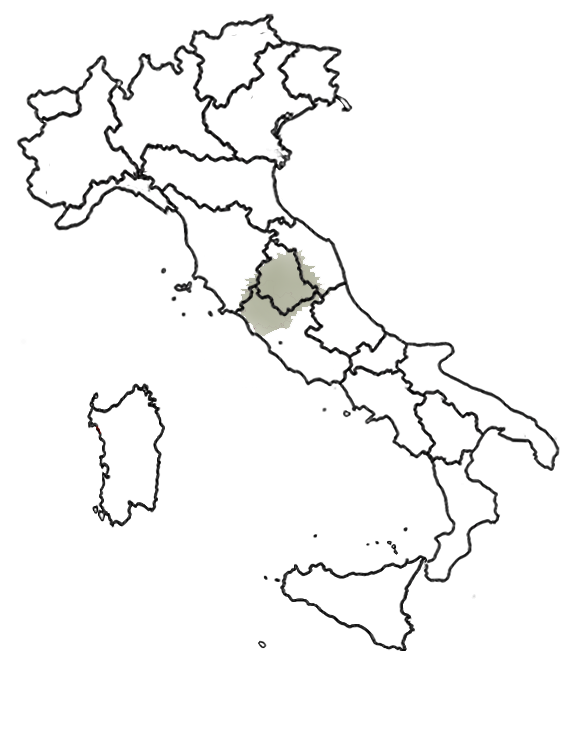|
|||
| C'era ’na volta
’l tonto, che la su’ mamma je disse: – Fijo mio, va ta ’l mulino a macinà ’sto sacch’ i grano. E, com’avem ditto, lu’ era tonto, e la su’ mamma ’n ce se fidava che lu’ ariportasse tutta la farina; che lìa eva temenza che ’l mulinaro ’l buggiarasse ta lu’, ch’era tonto; e perché lu’ s’aricordasse je disse lìa: – Bada che de diece n’arvenghin nove. Volìa di’ ’n p’ la moltura e tutto ’l resto. E lu’, volem di’ ’l tonto, ’ncol su’ sacc’ a l'orca, sen gìa p’ la strada e, manco a stancasse ’n momento, arpitìa: – Che de diece n’arvenghin nove. Perch’ete da sape’ che lu’ ’n se fidava del cervello. E camína, camína, èccheve che ’l tonto capìta posso ’n campo, ’ndù’ che se sommentava ’l grano: e lu’ sempre daje a di’: – Che de diece n’arvenghin nove. E l’arpitìa tanto pe’ n’n ascordasse che daje, daje, sentì qui’ contadini, che credetton che lu’ c’esse ’nguidia, e je mandasse ta loro la caristia; e ’l massacronno ’n ch’i bastoni; e lu’, porellino, manc’ arfiatava da le botte, e je disse ta loro: – Com’ho da di’ donca? E quilli j’ arispòsono che lu’ eva da di’: «Che de uno fussin cento». Volevan di’ che ’gn ’acin de grano s’aridoppiasse de tanto. E ’l por tonto ariprende la strada, e arpetìa: – Che de uno fussin cento. |
C’era una
volta il tonto, e la mamma gli disse:
– Figlio mio, va’ al mulino a macinare questo sacco di grano. E, come abbiamo detto, lui era tonto, e la sua mamma non aveva fiducia che le avrebbe riportato tutta la farina ; perché temeva che il mugnaio si sarebbe preso gioco di lui che era tonto; e perché se ne ricordasse, lei gli disse: – Bada che di dieci non ne ritornino nove. Lei intendeva la molitura e tutto il resto. E lui, il tonto, cammina cammina, col suo sacco in spalla, senza mai stancarsi un momento, ripeteva: – Che di dieci non ne ritornino nove. Perché, dovete sapere che lui non si fidava del cervello. E cammina, cammina, ecco che il tonto capitò in un campo, dove si seminava il grano; e lui continuava semre a dire: – Che di dieci non ne ritornino nove! Lo ripeteva tanto per non dimenticarsene, e dai e dai lo sentirono quei contadini, che credettero che fosse un invidioso che augurava loro la carestia, e lo massacrarono con i bastoni ; e lui, poverino, che non rifiatava dalle botte, a loro domandò: – Ma cosa devo dire dunque? E quelli gli risposero che doveva dire «che da uno ne vengano cento». Intendevano che ogni chicco di grano si moltiplicasse per cento. E il povero tonto si rimette in cammino, e lungo la via ripete: – Che da uno ne vengano cento! |

| Èccheve
’nto ’n paese je capita ’n morto de pesta che ’l
gìeno a sutterrà: e quilli del mortorio quan
sentìnno che ’l tonto dicìa: «Che de uno fussin
cento», se l’ebbon per male ’n bel po’, ’mo si lu’,
porellino, javesse fatto ’no scongiurio ta tutti; e
se fermonno ’nc’ la bara; e ’n po’ ’nchi fogolotti,
’n po’ ’nchi bastoni ne facettono ’n massagro de
lu’, che ma’ di mi’ giorni. E lu’ s’era misso a piagne, che ’n capiva gnente de quille botte che j’evon date; e quilli je disson che lu’ era ’no scrianzato, e ch’eva da di’: «Di’ l’abbia ’n gloria, Di’ l’abbia ’n gloria». Volem di’ ’l morto: e lu’, ’l tonto, p’ la strada del mulino sen giva arpetendo ’gni momento: – Di’ l’abbia ’n gloria, Di’ l’abbia ’n gloria. Volem di' 'l morto : e lu', 'l tonto, p' la strada del mulino sen giva arpetendo 'gni momento: – Di’ l’abbia ’n gloria, Di’ l’abbia ’n gloria. Èccheve che passa p’ na piazza de ’n paese, du’ che s’ammazzava ’na maiala: e sta bestia ciangottava, chè la scannàveno: e lu’ porellino, ’l tonto, dicìa sempre: – Di’ l’abbia ’n gloria, Di’ l’abbia ’n gloria. I norgini e j’altri del paese se creson d’èsse cojonati, e ’l fermonno ta lu’, e je disson che di’ n se mentòva quan se tratta d’ le bestie, che ’n c’òn l’anima ’ ’mo i gristiani; e ’nc le mazzarelle giù botte ta ’l por tonto, chè scontasse la bastigna. Quan lu’ se riabbe ’na mulica, j’adimandò ta i norgini e ta tutti quil ch’eva da di’ ’n cagno de «Di’ l’abbia ’n gloria». E quilli j’arispòsono che lu’ eva da di’: «Làssala gi’ ch’è ’na majala». E ’l por tonto ’ncomincia a caminà ’n prescia, che je s’era fatto tardi per ’rivà ta ’l mulino, e ’gni momento p ’r aricordasse, arpitia: – Làssala gi’ ch’è ’na maiala. E, porellino, èccheve che le capita ’nt ’na patuja de sposi, che se n’argìan da la ghiesa a fa’ ’l pranzo, e c’erno i parenti ’nco d’ le du parti: e pu’ c’evono ’l violino, ’l ciembolo e tutte le legrìe del mondo; e ’nto ’l passà d’ lo sposo, lu’, volem di’ ’l tonto, aripete forte, sempre p’r aricordasse: – Làssala gi’ ch’è ’na maiala. Adess’ sì che tutt’ i parenti de lìa, volem dì’ d’ la sposa, ’l pijòn pe ’l cotozzo, e ’l bujòn pe’ ’n fosso, ch’eran certa gente scojonata ’n bel po’, e se l’eron creso ’n insulto. Quan lu’ arviense for del fosso piagnìa ’mo ’na cannella, e je disse ta quilli: – Diceteme, cocchini; com’ho da dì’ donca? E quilli j’arispòsono che lu’ eva da dì’: «Tutte fussin como quilla» volem dì ’mo la sposa. E lu’ camína, camína; e arpitìa ’gni momento: – Tutte fussin como quilla. Quann’èccheve che ’riva ’nto ’n paese, du’ che c’era ’na casa che se brugiava. E lì ’nco l’arbastonno ta ’l por tonto che dicìa: «tutte fussin como quilla», che loro s’evon creso che lu’ dicisse d’ la casa che se brugiava, e facesse ’l malocchio ta l’altre case: ’nsomma lu’ porellino ’n sapìa più ta chi arcomandasse; e quilli je disson che lu’ eva da dì: «che Di’ lo smorzi, che Di’ lo smorzi» volem di’ ta ’l foco. ’L por tontarello, massagrato p’ le botte che j’evon date, tanto p’ r aricordasse arpitìa ’gni passo e ’gni momento: – Che Di’ lo smorzi. Quann’èccheve che tutt’a ’n botto se sbatte ’nto ’na casa, ’ndu che c’era la buttega de ’n fabbro, ch’era maestro de manescalco ’nco’. ’Sto porellino picchiarava de ’nanz ’i ’giorno p’ r apiccià ’l foco, che c’eva armedià ’n chierchio ta ’na carrettella, volem di’ ’mo si fussi stata ’na romagnola, e de prescia, chè ’l giorno posso c’era ’l mercato, e ’n fattore l’arvolìa la carrettella, e che fussi arcomidata per bene. Ma ta ’l maestro la lena ’n je s’appicciava, ch’era fràida, ch’eva piovuto; e ’l maestro daje ’n col soffietto, e la lena sfumigava, ma ’l foco ’n venìa ’gnun mò: e lu’daje ta soffià e bastignà ’mò ’no sbatizzato, che Di’ ce salvi ta tutti quanti semo. E ’n quil che ’l tonto passava de lìe, èccheve che ’l foco s’appiccia; e lu’, volem di’ ’l tonto, ’n s’aristellìa de di’: – Che Di’ lo smorzi; che Di’ lo smorzi. – E ’l fabbro che ’l sentì dì tisto, sfuriato ’mo ’n toro con quattro bastigne de core j’appiccica ’na martellata ’nt’ la zucca ta ’l por tonto, chè lu’ morì, porellino, e addì la mamma che ’nco’ lo spetta a riportà la farina dal mulino. |
Ed ecco che in un paese gli
capita un morto di fresco che andavano a
sotterrarlo : quando quelli del mortorio
sentirono il tonto che diceva «che da uno ne
vengano cento», la presero parecchio male, come se
lui avesse fatto un maleficio a tutti loro, e si
fermarono con la bara; e chi con le torce, chi con
i bastoni lo massacrarono tanto che non l'avevo
mai visto in vita mia.
E lui si era messo a piangere, e non capiva nulla di quelle botte che gli avevano dato. E quelli gli dissero che lui era uno screanzato, e che doveva dire: «Dio l’abbia in gloria, Dio l'abbia in gloria». S'intende il morto, e lui, il tonto, per la via del mulino, andava ripetendo di continuo: – Dio l’abbia in gloria! Dio l’abbia in gloria! Ecco che passa dalla piazza di un paese, nella quale si ammazzava una maiala: e questa bestia ciangottava, perché la scannavano; e lui poverino, il tonto, diceva sempre: – Dio l’abbia in gloria! Dio l'abbia in gloria! I norcini e gli altri del paese credettero che li prendesse in giro, lo fermarono e gli dissero che dio non si nomina quando si tratta di bestie, che non hanno l’anima come i cristiani; e poi con le mazzarelle giù botte al povero tonto, per fargli scontare la bestemmia. Quando cominciò a riaversi un pochettino, domandò ai norcini e a tutti che cosa doveva dire invece che «Dio l’abbia in gloria». E quelli gli risposero che lui doveva dire: «Lasciala andare, che è una maiala». E il povero tonto cominciò a camminare di fretta, perché si era tardi per arrivare in tempo al mulino, e per ricordarsi ripeteva continuamente: – Lasciala andare, che è una maiala! E, poverino, ecco che incontra un corteo nuziale, che andava dalla chiesa a fare il pranzo di nozze, con c'erano i parenti dello sposo e della sposa, e poi c'erano il violino e il cembalo e tutte le allegrie del mondo. Proprio mentre passava lo sposo, lui, il tonto, ripete forte, per non dimenticarsene: – Lasciala andare, che è una maiala. Ora sì che tutti i parenti di lei, della sposa, lo prendono per la collottola e lo scaraventano in un fosso, perché era gente parecchio scoglionata, e se l'erano preso come un insulto. Quando lui venne fuori dal fosso piangeva a dirotto e a domandò anche a loro: – Cari miei, ditemi allora come devo dire? Quelli allora gli risposero: «Fossero tutte come quella». E lui, cammina, cammina, ripeteva senza mai fermarsi: – Fossero tutte come quella! Quand'ecco chearrivò in un paese dove c’era una casa che bruciava. E anche stavolta lo bastonarono perché sentendo che diceva «fossero tutte come quella» avevano creduto che lo dicesse per la casa che bruciava, e che gettasse il malocchio su tutte le altre case. Insomma lui, poverino, non sapeva più a che santo raccomandarsi, e loro gli dissero che doveva dire: «Che Dio lo smorzi, che Dio lo smorzi», intendendo il fuoco. Il povero tontarello, massacrato per le botte che gli avevano dato, per non dimenticarsene ripeteva ad ogni passo: – Che Dio lo smorzi! Quand'ecco che tutto a un tratto si trovò davanti a una casa, dove c'era la bottega di un fabbro, che era anche maestro maniscalco. Questo poverino stava facendo di tutto per appicciare il fuoco, perché doveva riparare il cerchio di una carrettella, vi direi che poteva essere una romagnola, e andava di fretta, perché proprio quel giorno c’era il mercato, e il fattore rivoleva la carrettella, e che fosse ben riparata. Ma al maestro non si accendeva la legna, perché era piovuto ed era fradicia; e il maestro ci dava dentro col soffietto, e la legna fumava, ma il fuoco non ne voleva sapere: e lui giù a soffiare e bestemmiare come sbattezzato, che Dio ci salvi tutti quanti siamo. E mentre davanti gli passava il tonto, ecco che gli si accende il fuoco, e lui, il tonto, non smetteva di dire: – Che Dio lo smorzi, che Dio lo smorzi! E il fabbro che lo sentì, infuriato come un toro con quattro bestemmie dette di cuore gli tirò una martellata in zucca al povero tonto, e lui morì, poverino, e la mamma davanti a casa aspetta ancora che lui riporti la farina dal mulino. |
| RIFERIMENTI E NOTE |
|
| ___________________________________________ | |
| TESTO |
Angelo De Gubernatis, Rivista delle
tradizioni popolari italiane. Direttore
Angelo De Gubernatis, Roma 1893–1895. 2 voll. Anno
I, 1 Aprile 1894, fascicolo V, p. 353–356. |
| ___________________________________________ | |
| TRADUZIONE |
©
Adalinda Gasparini 2010, rivista nel 2025. SI è tenuto
conto delle note di De Gubernatis. |
| ___________________________________________ | |
| IMMAGINE | Bruegel, Pietr il giovane, Il ladro
di nidi; da https://www.akg-images.co.uk/CS.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMDHUQQX548&LANGSWI=1&LANG=French;
ultimo accesso: 6 maggio 2024; immagine modificata da
A.G. |
| ___________________________________________ |
|
| NOTE |
|
| Dalla
pianura fra Perugia e Assisi... |
Ho
trascritto questa novellina (notissima sotto
forme diverse nel mondo
del Folk-lore) nel dialetto contadinesco usato
nella pianura fra
Perugia e Assisi, ch’è abbastanza diverso dagli
altri del contado
perugino, anche perché esso tende a sparire con
molta rapidità: ho
cercato di trascrivere colla maggior fedeltà
possibile le forme
dialettali; le poche note illustrano quelle un
po' più difficili a
chi non conosce questo dialetto. Avvertirò poi
che le vocali e e a o
sono da pronunziare chiuse. (De Gubernatis,
cit. p. 353, nota 1) |
| Lieto fine
mancante? |
Ai bambini piacciono queste storie
del tonto già dai primi anni delle elementari, perché
ascoltandole si rendono conto della loro competenza
metaforica. Ascoltando fiabe come Giovannin senza paura
di Calvino godono del fatto che questo personaggio
assolutamente impavido - diversamente da loro - pur
avendo conquistato un castello con molte ricchezze
muore vedendo la sua ombra, o vedendosi il didietro,
dopo essere stato così incauto da farsi tagliare la
testa. Il lieto fine manca dalla favola, ma c'è per i bambini, che già alla scuola primaria capiscono il valore metaforico del linguaggio, ignorato dal povero tonto. Se si narra invece la fiaba a bambini troppo piccoli possono mettersi a piangere, perché non hanno ancora la capacità di distinguere il valore metaforico e finzionale del linguaggio. Resta la compassione per il povero tonto, che non ha fatto male a nessuno, e la percezione della crudeltà di chi non perdona, fino a uccidere bestemmiando senza ragione. Il povero tonto è l'opposto complementare di Giufà? andrebbe indagato questo tema, tenendo presente che Giufà agisce e parla per conto suo, mentre il tonto segue alla lettera le istruzioni materne e quelle di ogni altro. Andrebbe indagata la ragione per la quale nessuno si mette a insegnare qualcosa al povero tonto: perché il difetto della norma deve essere rimosso perché la norma sia accettabile? |
| FABULANDO
CARTA FIABESCA DELLA SUCCESSIONE |
Vedi
questa fiaba anche in formato e-book con altre note.
[Traduzione non aggiornata] |
online dal 10 gennaio 2003
ultima revisione 31 ottobre 2025